
“Alcuni anni fa, accusato di mancanze morali, un prete veniva trasportato su un carro per le vie di Napoli seguito da una folla imprecante. Ma ecco che a un angolo comparve un corteo nuziale. Il prete si levò, impartì la benedizione e tutti quelli che erano dietro il carro caddero in ginocchio”, raccontò il filosofo Walter Benjamin (1892-1940) in Immagini di città. Come dire che il cattolicesimo ha in quella città – o almeno aveva nel 1925, anno di pubblicazione dello scritto firmato assieme ad Asja Lacis (1891-1979) – un’autorevolezza indiscussa e vissuta soprattutto nella vita quotidiana.
Oggi in quel carro molti metterebbero la scienza, non perché abbia mai avuto (nel XX secolo, almeno) tanto spazio nella quotidianità per esserne infine sempre osannata, ma perché negli ultimi mesi alcune sue affermazioni sono state fruite e ascoltate dalla maggior parte della popolazione, prima con partecipazione, poi anche con dileggio. Sì, in quel carro, molti metterebbero la scienza o, meglio, gli scienziati, o meglio ancora i virologi, accusati di aver fatto in questi mesi di coronavirus Covid-19, affermazioni spesso contraddittorie: mascherine no, mascherine sì; banale influenza, virus micidiale; pericolo grave per i polmoni, allarme serio per tutti gli organi del corpo; sensibile al caldo, non sensibile al caldo; trasmissibilità diminuita, contagiosità continua; pericolo scampato, minacce incombenti, ecc. ecc.
E per il momento, pur con un po’ di timoroso rispetto, in pochi sono disposti ad inginocchiarsi di nuovo di fronte alla “parola-benedizione degli scienziati”. All’inizio gli esperti virologi (ma anche gli infettivologi e gli epidemiologi) sono stati messi sul piedistallo. E i mezzi di comunicazione di massa, alla ricerca della notizia del qui ed ora, hanno accelerato la costruzione del loro piedistallo che, però, si è dimostrato più fragile e problematico di quanto sperato.
Sperato perché di fronte alla tragedia prodotta da questo Coronavirus ha suonato immediatamente falsa l’atmosfera paciosa del pane e nutella ostentatamente mangiato come traduzione della filosofia dell’uno vale uno. “No – si è giustamente affermato – ora occorrono gli esperti, coloro che si basano sulla scienza”. Poi le tante contraddizioni affermate.
Cento anni fa, il 14 giugno del 1920 moriva Max Weber (nato nel 1864), uno dei più grandi sociologi dell’era contemporanea, noto soprattutto per la sua opera sul protestantesimo e lo spirito del capitalismo, che in quest’ultimo vede la decisiva impronta del primo. Un anno prima della morte pubblicò due importanti conferenze tenute all’università di Monaco, una sulla “scienza come professione” (Wissenschaft als Beruf), e l’altra sulla “politica come professione” (Politik als Beruf). Mi soffermerò un attimo sulla prima per inquadrare il discorso sulla scienza.
Ma che cos’è la scienza e chi è lo scienziato, suo ufficiante, per Weber? Per darle una fisionomia più chiara è necessaria una precisazione: in tedesco la parola “beruf”, oltre a “professione” e “lavoro”, significa anche “vocazione”. Il lavoro, in questo caso il lavoro dello scienziato, deve essere totalmente disinteressato e i suoi risultati scientifici “valgono per loro stessi” indipendentemente dai loro “successi tecnici”, come sottolineò Weber.
Nel quadro accennato una sovresposizione mediatica viene facilmente letta come un cedere alle lusinghe della facile celebrità e avrebbe ricevuto un forte biasimo da Weber: “Nel campo della scienza – precisò nello scritto citato, versione italiana curata dallo storico Delio Cantimori (1904-1966) – non è certo una ‘personalità’ colui il quale al modo di un impresario, porta sé stesso alla ribalta insieme con l’oggetto a cui dovrebbe dedicarsi”.
Quindi più parsimonia sulla propria immagine, si potrebbe dire, atteggiamento però raramente seguito da diversi ricercatori in questi ultimi mesi e che ha spinto (pur col consistente aiuto dei social media e degli altri mezzi di comunicazione di massa) a vedere il singolo scienziato come “un capoe non un maestro”.
Visione sommamente deleteria per Weber che ne rimarcò la scorrettezza quando rimproverava quegli studenti che andavano a lezione “per ricavarne un’esperienza che non consista soltanto in analisi e in constatazioni di fatto”, quindi no ai giudizi di valore che non si addicono alla scienza. Mentre “anzitutto, naturalmente, la scienza offre nozioni sulla tecnica per padroneggiare la vita rispetto agli oggetti esterni e rispetto all’azione umana, mediante il calcolo”, più “i metodi del pensare, gli strumenti e la preparazione a quello scopo”. Il tutto in un quadro di “chiarezza”, a patto che lo scienziato “naturalmente” la possieda, la chiarezza su questo metodo scientifico.
A questo punto è utile precisare che, storicamente, Weber si situa a un bivio: a valle di un momento di grande (e in parte, diremmo oggi, ingenua) fiducia nel pensiero scientifico e a monte di iniziali fragilità di quest’ultimo (quadro ben chiarito dal filosofo Massimo Cacciari nel suo recentissimo Il lavoro dello spirito. Saggio su Max Weber). Ma la potenza delle osservazioni del grande sociologo illumina anche l’oggi.
Chiarezza, quindi, come elemento indispensabile. Ma come può esserci chiarezza se diversi scienziati, forse tirati per la giacchetta, hanno fatto affermazioni sul Covid-19 senza precisarne i passaggi, senza chiarire cioè l’iter e il contesto teorico che ha portato a quei risultati? Dando così l’impressione di affermazioni apodittiche e causando in tal modo varie contraddizioni, oltre che con se stessi in tempi diversi, con altri ricercatori. Weber, anche in questo caso, è stato molto chiaro: “Nessuna scienza è assolutamente priva di presupposti…” perché la scienza è “un sapere”, che presuppone “i metodi del pensare”, e non “un possedere” tipico degli atteggiamenti di fede.
Con in più la considerazione che l’accrescimento delle conoscenze scientifiche attorno a un virus prima sconosciuto, come il Covid-19, è un progredire che non avviene di colpo ma passo dopo passo con l’intervento e il concorrere di diversi fattori: teorici, sperimentali, clinici e ambientali, che contribuiscono con modalità e tempi differenti. Falsificandosi, a volte e progredendo, altre. E modificandosi più o meno velocemente con ipotesi, casualità ed esperimenti, sino ad un risultato considerato positivo, ma pur sempre negoziabile.
E Weber in poche frasi chiarisce molto bene il nucleo del progredire scientifico. Facendo un parallelo con l’opera d’arte, che quando è “veramente ‘compiuta’ non viene mai superata”, per l’autore de La scienza come professione “viceversa, ognuno di noi sa che, nella scienza, il proprio lavoro dopo dieci, venti, cinquanta anni è invecchiato. È questo il destino, o meglio, è questo il significato del lavoro scientifico (…)”.
Ed ancora: “Ogni lavoro scientifico ‘compiuto’ comporta nuovi ‘problemi’ e vuol invecchiare ed essere ‘superato’. A ciò deve rassegnarsi chiunque voglia servire la scienza. Senza dubbio, vi sono opere scientifiche che possono conservare durevolmente la loro importanza come ‘mezzi di godimento’ a causa delle loro qualità artistiche, oppure come mezzi per educare al lavoro.
Ma essere superati sul piano scientifico è – giova ripeterlo – non solo il nostro destino, di noi tutti, ma anche il nostro scopo. Non possiamo lavorare senza sperare che altri si spingano più avanti di noi”. Affermazioni teoricamente importanti e deontologicamente potenti.
Tornando al carro iniziale, probabilmente, molti scienziati di oggi avranno capito che per mantenere l’autorevolezza della scienza da loro impersonata (a meno che non la si voglia solo maldestramente recitare) occorre non dimenticare mai che, weberianamente, si deve essere “maestri” e non “capi”. E il mondo politico, da parte sua, dovrebbe capire che adottare scorciatoie comunicative soddisfa probabilmente l’appetito del qui ed ora notiziabile, ma non certo quello dell’informazione corretta.
In una società complessa, come è la nostra, va tenuto conto, da parte di chi governa, che anche gli scienziati sono fatti di carne e sangue, e relativi pregi e difetti; mentre è ad altri, esperti della comunicazione e divulgatori scientifici, che andrebbe affidato il compito di un’informazione così delicata, se si vuole che sia più correttamente esplicativa e, quindi, meno contraddittoria e più fruttuosa.
Roberto Paracchini

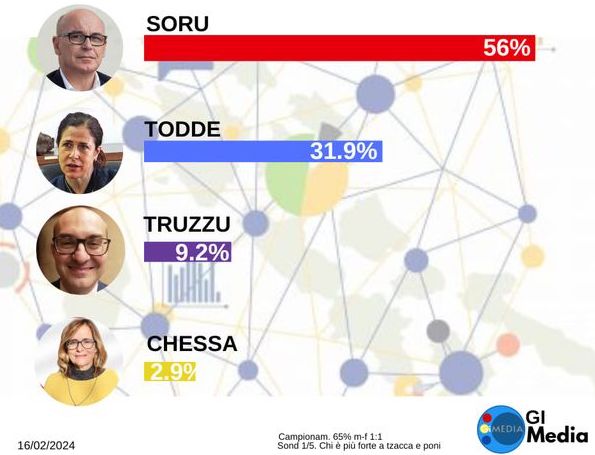




Caro Robertino,
apprezzando lo sforzo, bisogna purtroppo notare che la confusione attuale (tutta italiana, si badi bene) non deriva da mancanze da parte degli scienziati (la cui definizione weberiana è storicamente superata) quanto da due fattori contingenti:
– l’ignoranza dei cittadini per quanto riguarda il metodo scientifico; che la nostra scuola ignora largamente, anche a livello universitario;
– ma soprattutto l’ignoranza dei giornalisti, come dimostra il tuo intervento.
Affermare che ci sarebbe confusione nelle comunicazioni ai mass media da parte degli scienziati, infatti, significa ignorare come procede la scienza. Per capire cosa stia succedendo, bisognerebbe essere in grado di leggere i lavori specialistici degli scienziati di cui si chiede un parere, perché è ridicolo aspettarsi che un infettivologo o un epidemiologo possano spiegare nei pochi minuti concessi dalla televisione le basi delle proprie affermazioni. Poiché ciò è impossibile (soprattutto in un paese come l’Italia) ci vorrebbero giornalisti capaci di farlo, di mediare tra lo specialista e il cittadino (in altri paesi ci sono, come chiunque può verificare leggendo quanto appare nella stampa estera). Invece i nostri giornalisti scrivono nei termini in cui lo fai tu, parlando di confusione quando ci sono semplicemente opinioni discordandi su una materia tutta in itinere. Come quell’ignorante di Boccia (un ministro!) che ha detto e scritto simili assurdutà.
E’ duro dirlo, ma gli italiani (e i sardi) hanno i politici e i giornalisti che si meritano.
Ciò detto,grazie dello sforzo, che si situa tra l’inutile e il controproducente.
C’è di peggio, comunque, ad esempio le sciocchezze di Cacciari, visto che l’hai citato. Da cui: gli italiani hanno i filosofi che si meritano.
Una buona e meritoria interpretazione dei “Soloni” contemporanei quella individuata dal collega Roberto Paracchini.